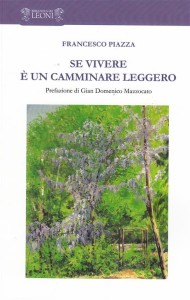SE VIVERE È UN CAMMINARE LEGGERO
LE LIRICHE INEDITE DI FRANCESCO PIAZZA
Francesco Piazza (Venezia 1931 – Treviso 2007) ha pubblicato i libri di liriche Alberi Anime (1985, ed. Circolo Culturale Teorema) e Mendicavamo canti di usignoli (1992, ed. La Stamperia dell’Ariete). Dopo la sua morte, dal riordino dell’archivio di casa Piazza, è emerso un poderoso corpus di versi inediti.
La poesia di Piazza è dotata di una sua specifica sigla. Vigorosa, splendidamente e luminosamente originale. La traccia di una forte personalità artistica e di una geniale e inquietante capacità di riflettere sull’uomo e suoi misteri esistenziali.
La forza, anche, di immagini e metafore costruite, elaborate, suggerite al lettore nel segno dell’inedito. Del ripiegamento interiore e, ad un tempo, dell’apertura alla natura e all’umanità. Un modo di affetti caldi e sinceri. Un umanesimo particolarissimo e toccante.
Sicché questo Se vivere è un camminare leggero si propone anche come chiave di lettura dell’opera grafica e pittorica del grande artista trevisano.
Io mi credetti padrone
della mia triste discesa
e so che non volesti lasciarmi
al crollo di chi precipita.
Francesco Piazza
L’arsura, in giro; un martin pescatore
volteggia s’una reliquia di vita.
La buona pioggia è di là dallo squallore,
ma in attendere è gioia piú compita.
Eugenio Montale, Gloria del disteso mezzogiorno
È per te che scrivo, anche se tu sola leggessi
e dopo di te nessuno,
anche se il tempo dovesse cancellare parole e pensieri,
anche se un giorno di ciò si dovesse sorridere,
è per te che scrivo e un solo attimo della tua gioia
di fanciulla amata io lo darei per la vita.
(Francesco Piazza, 19 giugno 1955)
Cosa aggiungono i versi che appaiono in questa silloge a quanto conoscevamo del mondo poetico di Francesco Piazza? Domanda che non si può in alcun caso eludere quando si affronta il mare ignoto dell’inedito e del riemerso.
E anche: domanda connessa all’effettiva volontà dell’autore circa la pubblicazione di materiale, in questo caso, molto cospicuo. Non avevano, questi versi, sufficiente dignità? O non esprimevano compiutamente poetica e mondo emozionale dell’autore stesso?
La lettura rivela un universo complesso, affidato ad un eloquio diffuso ed espresso con linguaggio ora colto ora quotidiano. Che proprio in questa dialettica tra aulico e quotidiano trova quella tensione che ci è nota, ma non finisce mai di rivelarsi.
Una fertilità, una felicità del dire che giustifica ampiamente il recupero dell’inedito.
I versi che appartengono al decennio ’55/’65 (e poi continuano per tutti gli anni Settanta) circoscrivono una poetica che potremmo chiamare dell’attesa e del ritmo.
Nel senso che esiste nel poeta la disponibilità al dono (a ricevere o a essere egli stesso dono). Una disponibilità che si rinnova ciclicamente e trova immagine nell’alternarsi di giorno e notte, nel rinnovarsi delle stagioni.
Esiste un luogo deputato all’attesa? Fisico o mentale. Perché questo pare essere l’assillo di Piazza. Il suo studio e tutta la sua casa, il suo stare in plein air, il tornare da un’assenza (breve o lunga) e ricevere l’affetto di chi lo ama. Viene in mente un sorriso di Jules Renard, l’autore di Pel di carota: se si costruisse la casa della felicità, la stanza più grande sarebbe la sala dell’attesa.
Non è così semplice, non è pacifico.
L’attesa può essere dramma, sussulto, speranza e disperazione: Quando il mio orizzonte è deserto /e scompaiono i monti azzurri / io mi richiudo nell’ombra. / Lascio le nubi salire / e scomparire i raggi del sole / che da esse gemendo sfuggono / per ritornare come lame di spade.
L’attesa si colloca nel cerchio di un orizzonte che si spopola. Un nulla, un deserto. Condensa in respiro breve i monti azzurri, le nubi che salgono. Poi i raggi solari nel gemito del tramonto e il loro riaffiorare, come spade affilate.
È la forza immaginifica della poesia di Piazza. Gorgo di energia coinvolgente. Chiama (e qui esiste contiguità assoluta con la pittura e l’incisione) il silenzio, in una rarefazione di sentimenti ed emozioni. Perché il Silenzio si fa nume e divinità e svela i palpiti più segreti e remoti. I sussurri vitali. Perché credo di udire / lo smunto ritorno dell’eco / se per nessuno io manco. / E di nessuno io saluto / pianti di dipartita? / Chi mi ha lasciato o di quale / mano sull’uscio attendo / il premere, certo, al ritorno? / L’ombra che mi accompagna / è di sentieri in sole, / e non la posso stringere / come donna tremante.
L’eco che si riduce a smunto ritorno innesca la relazione (e il confronto) tra presenza e assenza, tra ombra e sentieri solari, tra carezza e tremito di donna. C’è una sensualità (splendidamente barocca nei modi) che è dell’anima e del corpo, tra separazione e contatto fisico affidato alle mani (né è dato sapere a quale mano tocchi in sorte il premere).
Circola qui, dilatato e invasivo, un senso alto del mistero. Che è il procedere stesso dei passi sul cammino dell’umano esistere.
Un avanzare che schiude e implica relazioni e interrogativi. Una ricchezza, comunque si consideri. La vita è un debito che si contrae e per il quale bisogna avere un grazie sempre pronto e disponibile ad essere pronunciato: Grazie per tutto ciò, che, impossibile, / è balenato come scoppio di luce / alla tua magica mano / e per le ombre tenere, tese / al passo tuo docile e piano. / Grazie per quelle dita leggere / che sogni e speranze tessevano / e per quei tuoi sorrisi / che sfioravano cose e pensieri.
Ringraziare per i debiti che si contraggono e si portano addosso come una sorta di zaino da svuotare / riempire di continuo: un paradosso a ben vedere. Non è paradosso l’impossibile che diventa possibile in uno scoppio di luce? E non è paradosso l’appuntito ossimoro che restituisce equilibrio all’anima? …la savia pazzia lavora / per livellarmi l’anima.
Stare a livello, sentire il mondo come qualcosa di liscio, senza scalini: Da questa riva che guarda nel liscio mondo dell’acqua…
Da questa riva. La savia pazzia implica anche la scelta di un preciso punto di vista. E meglio sia che la strada / io la percorra di lato, / e a passi senza rumore / sui ciuffi d’erba, io vada / come se scalzo e il vento / non vi vedrà giungendo. / Io mai potrò nella sera / usci sospingere ansando / per la soave attesa.
Ecco, ancora l’attesa. Soave? In realtà tende agguati o almeno sforna una sorpresa dietro l’altra. Affiorano i sogni, i miraggi, le intuizioni. Una serie di messaggi (come dire? sottocoscienza) che sono la verità “altra”, quella che allude (conduce?) al metafisico, all’ultraterreno, al numinoso.
Insomma la verità che davvero conta e pesa.
Con marchi roventi in mano / ho vegliati nel sonno stanotte / in anelanti agguati attesi / le ombre dei miei pensieri. / Essi sgusciavano, corsa / di ansimanti vitelli in fuga / e straripavano, ombre / di assedianti pensieri. / Se col pugno proteso / in fronte li avessi segnati / all’alba li avrei rivisti / ed additati ridendo.
Questo è il problema vero. Anche se evanescenti, anche se sfuggenti, fantasmi e miraggi sono indizio di una realtà autentica. Serve, in qualche modo, nominarli, catalogarli, inventariarli. Perché qui abita la risposta alle domande dell’umano esistere. Qui è la musica totalizzante (e didattica, magistrale, irrinunciabile) dell’universo: hanno cantato le fibre / più silenziose e quiete / ed ho sentito immobile / la vetta sotto i miei piedi.
Altrove: Lo spazio che canta al mio fianco. / Ho sempre le orecchie tese / come reti di ragno.
Le fibre silenziose e cantanti, ancora un paradosso / ossimoro. Le fibre ultime, le più riposte, la canzone più dimenticata, quella che nessuno suona mai. Lì, nel mistero, lui avverte la vibrazione della vetta, sotto i suoi piedi. Affascinante. E profondamente vero.
I miraggi. Ne parla con toni struggenti: E quando gli occhi indugiano / in trasparenze di pace / o in me guardano forme / di fantasiosi miraggi, / cosa più dolce di attendere / il battito delle sue ciglia / e il guizzo di dolce abbandono / attento prendere e farne / ricordo di debolezza.
L’attesa di un battito di ciglia, un guizzo di eternità. Le trasparenze di pace si accompagnano all’anima fatta di vetro, di cui si dirà tra poco.
A far funzionare questo metronomo che conta le oscillazioni dell’anima (a farlo funzionare tecnicamente, voglio dire, nella precisione della parola che si fa inchiostro e scrittura) è la ricerca instancabile dell’interlocutore. Un “tu” dilatato, immenso, (onni)inclusivo: Sei l’eco del monte, feroce / ripetuta dal nudo sperone / nell’occhio della coturnice. / Sei l’ansa del fiume, brillante / come squame di pesce d’argento, / fremente di lunga ricerca. / Sei l’impossibile acqua / ch’io berrei dal ghiacciaio azzurro / se solo vi potessi giungere.
Piazza disegna con vigore il profilo di questo “tu”, non si limita a evocarlo.
Anima fatta di vetro, / filata come seta d’oro, / lama sottile d’argento / nel buio dell’abbandono, / occhio spaurito, battuto / dall’ombra di mobili ciglia, / arco di cielo sereno, / striscia di mare immenso, / e completezza di amore, / resta ad incidere segni / di beatitudine amara, / e più che puoi vola / come assetata di pianto.
Un identikit preciso che ruota ancora attorno ad un ossimoro, vero e proprio stilema, come appare a questo punto evidente, della poesia di Piazza (beatitudine amara, il dolceamaro che la classicità riferisce spesso alle pene d’amore).
Infatti, a dettare le regole di questo straniante oscillare tra opposti, è pur sempre la sua carne d’uomo. So che dovrò cercare / tronchi abbattuti o sentieri / quasi ignorati e la notte / umida mano di amica / mi chiuderà, nel bosco, / gli occhi tesi a vedere. / Come di morti padroni, / o lepre selvaggia e sola / è chi mi vive dentro / alla mia carne d’uomo.
Che è uno straordinario (praticamente completo) catalogo degli “oggetti” della poetica di Francesco. La ricerca della via (preferibilmente sentieri), il bisogno di punti di riferimento, la notte come crogiolo di ogni emozione, la similitudine tratta dal mondo degli animali (la lepre, in questo caso, come sempre selvaggia e immersa nella solitudine), specchio della vita interiore. E poi appunto, folgorante, la carne d’uomo.
Fragile e, proprio in virtù della sua fragilità, un tutto.
Va da sé. Su tutto incombe un poderoso senso del tempo. Che ha pause, sospensioni, fughe, enigmi. Ma è anche duro, vivo, presente. L’hic et nunc mediato dalla parola. La tua parola è tenera / ed è neve e pura / come solo è nel sogno. / Vieni prima che il tempo / ti scolorisca le labbra / e riprenda l’aria i capelli / che ora vicini mi appaiono.
E altrove: Ricordo ancora il colore / che aveva quel giorno la terra, / sento venire ancora / il breve passo del tempo. / L’autunno aveva veli / di trasparenti annunci / e come carne celata e vicina / il cielo di essi ammantava.
Un po’ più in là: sarà nostro conforto / il ritornare del tempo.
Come si diceva: la ciclicità, l’eterno ritornare del tempo su se stesso. La clessidra continuamente capovolta, l’identica sabbia per ogni ora. In filigrana si staglia la possente, enigmatica immagine dell’orologio assorto: Ecco che sale la notte, / ed il silenzio scivola / per tutta la casa, attenta / all’orologio assorto.
Anche se qualche paura offusca. Tende agguati: Non posso, grido, non posso / scrivere la tua anima / con i colori di spazi / tagliati dalla ragione. La cesura tra la parola e il segno grafico (o la pennellata). Non può bastare la ragione a dettare.
In quel giro di mesi scriverà anche: Mi lascio prendere dalle stagioni / ed ogni anno mi piace / meravigliarmi, / dell’estate improvvisa.
Lascarsi afferrare (attraversare, anzi) dallo stupore. Questione di pause e di riprese: Tutti tornano a vivere / come una pausa del sonno. / Avevo le stesse parole / di giorni lontani e gli occhi / uguale pace trovavano / nei gialli cespi di primule.
Dunque, come si diceva, anche una questione di ritmo.
Dentro al quale irrompono (non si saprebbe dire se con ironia o sulla spinta di una inguaribile melanconia, forse entrambe) i versi scritti nel 1958 fra Treviso e Castelfranco.
Piazza lavora alle Grafiche Trevisan, impegnate in quei primi mesi dell’anno nella stampa delle schede elettorali per le votazioni politiche (si sarebbero svolte il 25 maggio). Esplodono I canti dello stabilimento, sorta di minisilloge legata all’evento.
Tutti che contano (seicento donne!). Rinchiusi, prigionieri quasi. Piazza fa passare le otto ore contrattuali. Poi: Allora ho detto che vado. Il caporeparto (un camice bianco. Niente volto, niente corpo, solo il camice) gli dà con degnazione il consenso. Lui torna a casa, in treno.
È il nostos, il ritorno dell’eroe. Legge la vita stessa in quello sferragliare sulle rotaie: mi vado a contare / finestre di casolari / e bianche camice di uomini / nell’ultimo ravizzone. / Speroni nei fianchi mi additano / la corsa, nell’abile intreccio / di sentimenti e di cose. / Immenso esco, ho le spalle / che reggono il greve corpo / del vento.
Versi di grande respiro. Autobiografici. La propria esperienza come immagine universale della fatica di vivere.
Sulle sue spalle, novello Atlante, grava il peso del mondo. Il giorno dopo tornerà immergersi nel bailamme delle donne disfatte dalla fatica e dal sudore. Non le capisce proprio, non comprende il senso di quel correre e di quell’affaticarsi. Disincantato e cattivo. È tanto difficile scendere / ai loro cervelli d’insetto.
Questa silloge raccoglie anche versi scritti nella prima metà degli anni Novanta. È un nucleo contrassegnato da un tono più dimesso, meno discorsivo. Da una affiorante vena di stanchezza. Nel 1987 è mancata l’adorata Anna Maria.
Chi sta vicino a Checco avverte un vuoto, un’assenza, una voglia di ricongiungimento che circonda come un’aura l’artista. Una polvere sottile ma pesante. Si deposita su quanto dipinge incide, scrive. Oggi risento ancora / quel senso di finito, / di consumato, il nulla / tra un respiro profondo / ed un respiro che tarda a venire e che non viene.
È il febbraio del 1993. Due mesi dopo ribadirà: Mi sento sterile e stanco / come una squallida canna / ed ho la bocca amara / e l’udito mi inganna. / La mia vita è più lenta, / tutto mi si rallenta, / e la mia mano è vecchia / quando l’occhio mi cade / sul pennello…
Il poeta / squallida canna scopre il piccolo mondo, la dimensione che lo rassicura: ora mi posso assopire, / il fuoco dura / e questo mio piccolo mondo / di cani, di legna, di luce intorno / mi rassicura …
E fuori? Lo turba la trasformazione. Meglio, il degrado. Hanno venduto la terra / dove ondeggiava il frumento, / dove l’orzo mareggiava, / dove si ergeva il granturco / in paludamento di rosee, / eburnee pergamene. / La motosega morde / il mio cuore di legno, / l’orda delle acacie declina, / precipita in una caligine / di stecchi grigi.
Perfino il suo giardino, amatissimo e ritratto mille volte da mille angoli diversi, con ogni luce e in ogni stagione dell’anno, gli si configura in chiave ostile. …credevo il mio giardino / un paradiso ma nella notte stride / la morte. Urla di un topino / o di un passero disattento. / La civetta sghignazza / e al mattino la guazza / veste gli steli dell’erba / di camiciole d’argento.
No, meglio il piccolo mondo. Superbo, imperiale l’olocausto che si consuma nella stufa a legna che diffonde calore nel suo studio. Scoppietta l’acacia, / ronfa il castagno, / il faggio con lieve respiro, brucia. / Tutto canta il suo creatore / anche nell’olocausto della stufa.
Potrebbe sembrare un ripiegamento, una rinuncia.
Certo in qualche misura lo è. Ma si tratta soprattutto di una sublimazione del tema dell’attesa e del dono. Signore, nel dono dell’attesa / di una completa risurrezione, / dono di giorni preziosi / di nubi osannanti, di cieli pastosi, / di passeri terragni / ed arguti fringuelli / di prati maturi e di cespugli lucenti, / di trepidi alberelli / come piccoli angeli nel grande coro.
Tanti anni prima nella dedica di una lirica ad Anna aveva scritto: per quando la malinconia si traveste d’attesa.
Il Grande Silenzio stava già tramando, stava già tessendo agguati.
E dunque questi versi sono altissimo testamento spirituale.