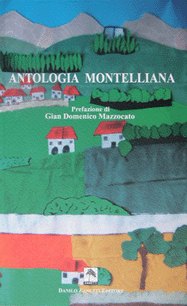 Antologia Montelliana
Antologia Montelliana
(Danilo Zanetti Editore)
Con racconti di:
Fabrizio Bonetto, Paolo Bressan,
Gianmauro Comazzetto,
Loris Curto, Lucio De Bortoli,
Loretta Menegon, Alberto Poloniato,
Gianluca Salogni, Alessandra Schiavinato,
Ruggero Tremonti, Marco Zampieri
La casa dove tutti gli oggetti si ricordano di me,
mi raccontano instancabilmente
la mia storia.
Corrado Alvaro
Si tratta di una terra mossa, un’introduzione lieve al verticale che segna l’inizio e la fine. Parte così, con questo esordio largo e inatteso, già struggente dalle prime sillabe, Dalla Morte, il bel racconto di Lucio De Bortoli.
Il lettore si trova ad inseguire subito l’enigma di Cester e i suoi misteriosi itinerari: Cester, l’uomo che guidava la Guzzi (una promozione rispetto alla sgangherata bici degli inizi) e non si perdeva un funerale. Quando De Bortoli gli tende un dolce agguato -lo vuole conoscere meglio, se possibile vuole provare a sciogliere un po’ il groppo duro di quell’esistenza ai margini- lo aspetta a un funerale. Ma Cester non viene e questo chiude il teorema con una dimostrazione assoluta: Cester è morto a sua volta, il prossimo funerale sarà il suo (se si troverà il corpo).
Racconto bello, bellissimo. E soprattutto esemplare. Perché è proprio il racconto -non il romanzo-, con la sua misura e i suoi spazi, la formula narrativa che meglio segue e segna il ritmo dell’avventura esistenziale dell’uomo, lo interroga sul suo destino, gli indica col dito fermo l’uscita, il momento del distacco, l’unico istante veramente autentico dell’esistenza.
Il racconto, meglio di ogni altro spazio narrativo, è indagine sull’uomo.
Si combina e si intriga con l’idea del vivere e del morire. Shahrazàd racconta al re Shahriyar una novella, dopo una notte d’amore, e distoglie il suo sovrano dal proposito di ucciderla (perché il sovrano odia le donne, le usa e poi le uccide: una ogni notte). Il gioco riesce a Shahrazàd per mille notti e anche per la notte successiva alla millesima. Nasce così il capolavoro della narrativa araba che si è propagato in ogni parte del mondo. Un rito, una liturgia per procrastinare la morte.
E se pensiamo, che so, al capolavoro assoluto della narrativa occidentale, il Decameron, da dove nasce il racconto dei dieci ragazzi se non dalla fuga da una Firenze distrutta dalla peste, una Firenze franta e in macerie, con le strutture sociali scardinate e dissolte sotto la furia devastatrice dell’epidemia? Che altro è il loro narrare se non un esorcizzare la morte e la disgregazione?
Così, Cester che irrompe con la sua rumorosa Guzzi (e che forse è un lupo), partecipa a tutti i funerali. Certo vede in essi la prefigurazione del suo e assurge così a memorabile emblema e blasone di questa Antologia Montelliana.
Come il vecchio Ruggeri, del resto, il secondo protagonista di De Bortoli, straziato dalle pale di un mulino, che innerva con la sua presenza ruvida questo dittico in chiaroscuro dell’umana esistenza.
A questa antologia hanno messo mano e talento undici scrittori, per una ventina di storie diverse. Due soltanto le presenze femminili. E una, per così dire, (si) racconta al maschile. Toni, stili, tagli diversi. Anche sottogeneri diversi. Dal diario al fantasy, con perfino qualche puntata sull’horror. Lettura bella e varia.
L’esordio della silloge è lasciato all’ironia abrasiva di Fabrizio Bonetto che, in due racconti, celebra (e irride con amarezza) i riti della convivenza. C’è la coda al supermercato dove vendono uno scontatissimo PC (ma a scombinare i conti intervengono un mezzo caso di coscienza e perfino un bagarino). I personaggi appaiono tutti impaniati nella colla, usata al posto dell’intonaco, che trattiene gli inquilini, come ingessati nei loro movimenti, condannati alla fila, alla coda. Che per l’autore diventa spazio e tempo per osservare gli altri. Tutti dentro l’ansia dissolutrice dell’acquisto.
Altro rito è la partita a scopone: chi arriva in ritardo deve pareggiare in fretta il vino bevuto dagli altri perché fare punti partendo da un grado di ubriachezza diverso, sarebbe sommamente sleale. Perfino inconcepibile.
Paolo Bressan racconta un’avventura asolana, di grande intimismo, originata da un bicchiere di Martini vuoto dove era rimasta una lieve traccia del suo rossetto.
Un racconto di impianto e taglio classici, dominato da una malinconia esistenziale assoluta. L’incontro è occasione per la tangenza breve di due storie. La memoria si annega nell’alcol, nella solitudine.
Schema (quello della breve interferenza tra due storie personali diverse e lontanissime) che Bressan riprende nel secondo racconto il quale appartiene al sottogenere (molto ben frequentato da scrittori di ogni epoca) del “mai scritto”. Una rivelazione finale che ha una colonna sonora scandita da parole sussurrate e da tre colpi cadenzati di pistola.
Gianmauro Comazzetto, propone, in due racconti, la suggestione e l’emozione che assale chiunque si renda conto di quanto fragile e tenue sia la soglia tra ciò che ci è noto e ciò che non conosciamo. Da dove viene l’ultima, risolutiva lezione di volo che salva la vita, evita il disastro? Da un territorio, da un oggetto, da una presenza che la fredda ed efficiente logica dei radar terrestri non può rilevare. E però risolve.
Come risolve (in senso etimologico, cioè scioglie un nodo) la scoperta di un tesoro. Banale perfino: ma come definire banale la scoperta di essere circondati dall’oro (e oro a quintali!) e decidere di non farne nulla? Far finta che tutto quel bendidio non esista: Comazzetto conduce con abilità straordinaria questo gioco col banale. E siccome di tesoro si tratta, non può mancare la relativa carta. Che diventa, però, non mappa di un’isola lontana, ma la geografia di una intera esistenza. Nonno Toni muore e lascia le tracce per trovare un tesoro: in realtà quelle tracce sono la storia della sua vita. Ereditare vuol dire ricostruire.
Loris Curto racconta due storie misteriose di discendenze arcane, di enigmi perpetuati da una generazione all’altra, di segreti spartiti con naturalezza (ma rivelati al momento opportuno). Una “ondina” capace di visitare i sogni, di essere lei stessa un sogno. E una ragazza dalla bellezza antica (identica al volto femminile ritratto in un altorilievo della Altino romana) è a sua volta depositaria di un segreto e di una tradizione millenaria. Lo scrittore dice che il mistero è tra noi, normale e quotidiano. Che esistono parentele e legami occulti. Che può succedere di imbattersi in chi, ancor oggi, sacrifica agli dèi Lari. Non sarà un caso che Celeste, l’ondina, recuperi un brandello di anima, la giustificazione stessa del suo (sopra)vivere, la condizione necessaria, anzi. Due fiabe moderne quelle di Curto, colte e, insieme, gentili e molto dirette.
Loretta Menegon scrive una lettera di affetto e memoria, rivelando lo scorcio di un incontro sospeso tra la tua fretta, il mio camminare morto.
E Alberto Poloniato racconta di una estate cruenta che ha per protagonista Jonathan Antenora, nome e cognome assolutamente strambi e apparentemente casuali.
Strambi forse, ma casuali no, come rivela il finale. Da leggere con attenzione: garbo (ma non troppo sia chiaro, di sangue ne scorre parecchio) e brio sono il tessuto connettivo di una vicenda del tutto normale. A tutti può capitare di frequentare un locale di nome Maracaibo (che si trova in centro) e di avere tre amici di nome Ernesto, Fabio e Carlo. A tutti, ma proprio a tutti, giura Poloniato, può capitare di trovarsi in mezzo ad una storia di vampiri.
Gianluca Salogni disegna le sue geometrie esistenziali in due racconti marcati da un insistito sperimentalismo espressivo. La vita è fatta di parallele e di perpendicolari. Un incidente di macchina che altro è se non un incontro di rette, di traiettorie? Assumere una pillola dietro l’altra che cos’è se non seguire la linea e il filo dell’esistenza? Anzi, per essere più rigorosi, che altro è se non cercare di starle dietro, di assecondarla?
Il racconto si snoda per associazioni successive suggerendo trama e intreccio che poi arrivano ad un nodo finale. Non sciolto. Un intrico, perché le geometrie sono un trucco -finzione e convenzione- rispetto ai ghirigori della vita, alle sue mille bizzarrie.
Alessandra Schiavinato ci ricorda che raccontare è soprattutto memoria. Nel primo dei suoi due racconti ci rivela, anche, di voler essere un uomo libero. Cioè si definisce al maschile. Nel secondo racconto si dà anche un nome, Augusto (abbreviato in Gusti). Raccontare di grande fascino, e non solo per questo gioco (amabile ma non innocente) dello sdoppiamento. Resta indelebile nell’anima, questo ragazzino che si mette due calzini di colori diversi: si capisce che lo fa per darsi, grazie ad una ingenua trasgressione, un codice, per costruirsi una filosofia capace di decifrare il mondo. E decifra, certo, con intelligenza e dolcezza. Come nell’inedita sinestesia dell’odore caldo di erba tagliata e rumori di ventole che ronzano. Di sera, Schiavinato ci guarda tutti dal bastione. Non per giudicare, di sicuro.
Ruggero Tremonti racconta, con sintassi classica e sorvegliata, due parabole esistenziali. Che sono due storie con un identico protagonista, Andrea. Andrea è colto nell’atto in cui si spogliò del passato. Solleva un vecchio del peso dello zaino e lo spinge verso la vetta: simbolismo evidente, perfino didascalico. Operazione, quella di spogliarsi del passato, difficile: non si può cancellare, semmai si deve ricostruire con criteri nuovi. Quando entra nella vecchia casa con otto fotografie alpine, Andrea è assalito da un pensiero abulico e confuso. Ricorda, in una assenza/presenza di sensazioni, un vecchio pianoforte mai suonato da tempo.
Chiude la silloge Marco Zampieri con una storia -bella e stralunata- di neve, di liquori, di uno spiedo mitico, reso pingue da un capriolo, un cucciolo che forse sta morendo di fame, di un igloo che c’è e non c’è. Il tutto in una dimensione temporale (atemporale?) in cui la vita scorre come le tracce di un CD. Si comincia con i Pink Floyd (i vecchi Pink) e naturalmente non si sa bene dove si va a finire.
Anzi, lo si sa, ma non è una cosa bella. Il rogo finale sembra cancellare il mondo. O ribaltarlo. Da una casa di ghiaccio (l’igloo, appunto) a una casa di fuoco.
GIAN DOMENICO MAZZOCATO
(Treviso, 1 dicembre 2004)